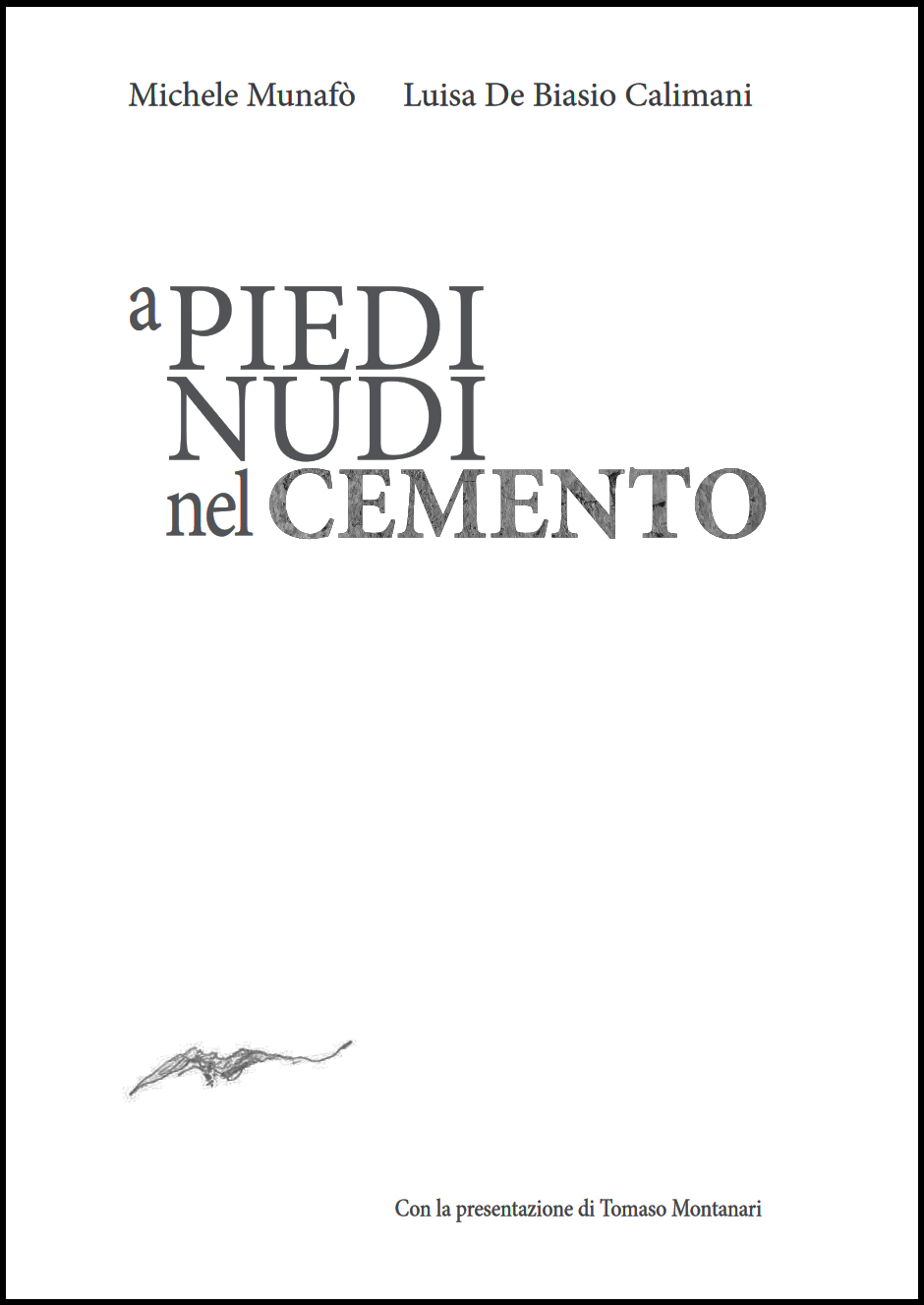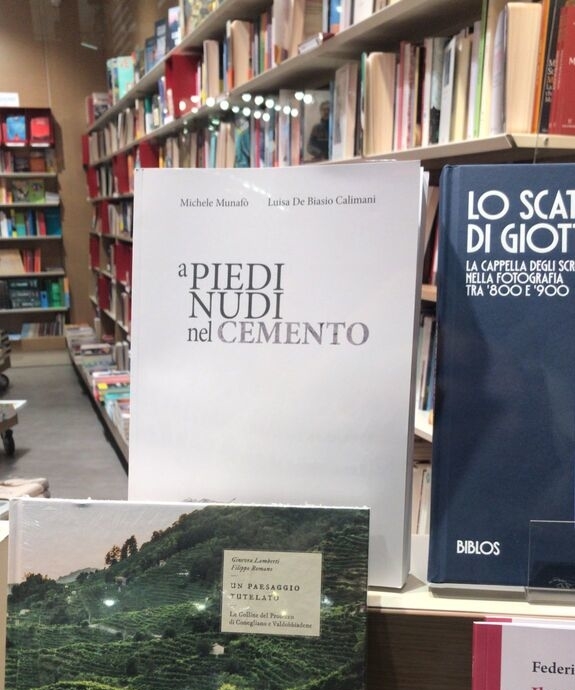Presentazione del libro “A piedi nudi nel cemento”
Presentazione di Tommmaso Montanari
«La città formò col suo territorio un corpo inseparabile»: questa affermazione fulminante di Carlo Cattaneo potrebbe essere un’epigrafe perfetta per questo bellissimo libro di Luisa Calimani e Michele Munafò.
Un libro singolare, prezioso: scritto da un ingegnere ambientale e da una urbanista, esso riesce a guardare la città con uno sguardo integrale. Capace appunto di tenere insieme il tessuto urbano e quello naturale, la questione sociale e quella ambientale, la storia e il futuro. Il risultato è un efficacissimo strumento politico: perché è la sorte della polis, non sorprendentemente, la partita cruciale della politica di oggi. È forse proprio per questo che la frase di Cattaneo appare così calzante: egli scriveva nell’Ottocento, e usava il passato remoto pensando alle città italiane dell’età comunale, nel Medioevo. Ma quelle parole si possono anche leggere come una profezia sul futuro: perché o si recupera un rapporto virtuoso, vitale, fecondo tra città e ambiente, o non ci sarà nessun futuro.
La città – le megalopoli sempre più sconfinate, le città trasformate in inceneritori dei vivi dal cambio climatico, le città a rischio di sprofondare sotto il livello del mare… – saranno il teatro della fine dell’umanità, o invece il laboratorio del riscatto? Questa domanda, carica di angoscia, non ha una risposta già scritta: a scriverla saremo noi, e soprattutto i più giovani – quelli che si definiscono, con giustificato allarme, l’‘ultima generazione’. Ed è proprio a chi è ancora capace di indignazione, e dunque di speranza, che questo libro si rivolge. È a chi intende lottare contro l’estinzione che questo libro serve.
Un libro pieno di dati, di storie, di idee: e dunque, innanzitutto, uno strumento di comprensione. Un’altra buona epigrafe, infatti, potrebbe essere l’ammonimento che Carlo Rosselli mormorava a se stesso e ai suoi compagni di fronte al nascente antifascismo, un secolo fa: «prima di agire, è necessario capire». La domanda che allora assillava i Rosselli e i loro amici («Perché questo crollo? Perché questa indifferenza?») non è diversa dalla nostra: perché l’umanità non si ribella alla sua estinzione prossima ventura? Una risposta sta nel modo in cui il potere economico e il potere politico governano il discorso pubblico. Chi vuole che nulla cambi ha paura delle parole: per questo anche un libro può fare la differenza. In Don’t Look Up (un film del 2021) una cometa sta per scontrarsi con la terra: e la reazione della classe politica è la negazione, la rimozione radicale. L’unico impegno è convincere tutti a ‘non guardare verso il cielo’: andando avanti come se nulla fosse, fino all’irreparabile. Questa efficace metafora di una umanità lanciata irreffrenabilmente verso il suicidio collettivo (tra guerre, pandemia e disastro climatico) parla (anche) della nostra Italia, dominata da una classe dirigente inadeguata quanto avida, capace di tradurre in colate di cemento e in fiumi di profitto privato anche un Piano di resilienza e ripartenza scaturito da una catastrofe ambientale, sanitaria e politica. Una classe dirigente che non vede il futuro prossimo di tutti, ma solo l’interesse immediato di pochissimi. E che dunque continua a banchettare sulla nave che ormai sta affondando. Ma se in Don’t Look Up gli eroi positivi (che pure falliscono) sono vistosi scienziati eccentrici, quelli che fra noi provano a fermare la macchina hanno un profilo assai più normale. Donne e uomini che continuano a fare il loro dovere: studiando, insegnando, applicando le leggi pensate nell’interesse generale. Scrivendo libri come questo.
Nelle prossime pagine tutto serve a capire, a farsi un’opinione. Non necessariamente sempre identica a quella degli autori: perché, come ogni vero libro, anche questo riesce a risvegliare efficacemente il pensiero critico, a mettere in grado il lettore di pensare autonomamente su questi temi.
Io, per esempio, non credo affatto che l’inserimento esplicito dell’ambiente nell’articolo 9 della Costituzione sia stato una buona idea: la Corte Costituzionale aveva da tempo chiarito che nel «paesaggio» dell’articolo 9 era tutelata tutta la biosfera. Ma ora, l’aver separato in due beni diversi da tutelare paesaggio e ambiente rischia non solo di essere inutile, ma anche dannoso. Il rischio è che ne nasca una giurisprudenza che opponga l’uno all’altro, cioè che permetta di sacrificare il paesaggio in nome dell’ambiente (quasi fossero cose diverse!): l’effetto (forse voluto dal nuovo costituente) potrebbe essere quello di aprire la porta a un ambientalismo industriale sviluppista che sacrifichi suolo e paesaggio ai parchi eolici e fotovoltaici. Rischiamo cioè di comportarci – si perdoni la similitudine – come un tossico che pur di continuare a bucarsi, cioè pur di non rinunciare al dogma della crescita, vende, perdendoli per sempre, i gioielli di famiglia – cioè il paesaggio italiano, bene non rinnovabile se devastato oltre un certo limite: limite, come è noto, largamente già oltrepassato in molte sue parti. Laddove, come ben si spiega in questo libro, la transizione energetica si può e si deve coniugare con la tutela dell’ambiente. In ogni caso, comunque la si pensi, è di queste cose che dovremmo parlare, discutere: e ogni tentativo di accendere questo confronto va accolto come una benedizione.
Infine, oltre che a capire, questo libro serve a prendere parte: a schierarsi.
A schierarsi per il bene comune, e contro l’interesse privato. Per una vera pianificazione, e contro l’urbanistica contrattata. Con chi ha il coraggio di parlare apertamente nel discorso pubblico, e con chi ha la forza di amministrare con lungimiranza e rettitudine la propria città. Accanto alla documentata denuncia di ciò che ci sta portando alla catastrofe, infatti, nelle prossime pagine c’è anche un’importante pars costruens, che descrive buone pratiche ed esperienze riuscite, tratteggiando così un vero manuale di buon governo delle città: per questo si tratta di un libro da regalare ad ogni sindaco italiano.
Uno dei motti della falange franchista, nella Spagna della guerra civile, era «viva la morte, abbasso l’intelligenza!». Potremmo dire che ancora oggi questo è il motto di chi propugna una crescita infinita in un pianeta finito, di chi condanna la città a ridursi, da luogo di liberazione per eccellenza, in luogo di schiavitù e di morte. Per questo, il motto di un libro come questo non può che essere: «viva la vita, viva l’intelligenza»!
Tomaso Montanari
Professore ordinario di Storia dell’arte moderna
Rettore dell’Università per Stranieri di Siena
Introduzione al libro
La complessità dell’organismo urbano e del territorio in cui è insediato richiede, per una sua articolata
lettura, il contributo di più saperi, di esperti in diverse discipline, ma soprattutto degli “utenti”, degli
“attori” e dei “registi” della città.
Il filo conduttore della narrazione di questo libro è la stretta relazione tra l’ambiente costruito e
l’ambiente naturale, che ci racconta la difficile sfida che le città, il luogo dove vive gran parte della
popolazione mondiale e che sono responsabili delle maggiori pressioni sull’ambiente, devono oggi
affrontare di fronte alla crisi ecologica e ai cambiamenti climatici, intrecciandosi con i temi dei servizi
ecosistemici, dei processi insediativi, della forma della città, del consumo di suolo, dei diritti urbani,
della democrazia, delle periferie, delle diseguaglianze, della rendita…
Una visione olistica della città, la lettura del suo presente e la proiezione del suo futuro non possono
formularsi ponendo le infinite tematiche che riguardano la città sullo stesso piano, come finora è quasi
sempre avvenuto. È, invece, imprescindibile imporre delle gerarchie che sottomettano ai temi
ambientali qualsiasi altro interesse, poiché di questo sovvertimento ne beneficerà l’economia, la
salute, il benessere della popolazione e del pianeta.
Il libro affronta ogni tema con quest’ottica, capovolgendo il tradizionale approccio onnicomprensivo
e paritetico alla città, rivoluzionando i paradigmi di lettura e le proposte per il suo sviluppo futuro,
mettendo in discussione la tradizionale definizione di sviluppo che ha dimostrato di essere inadeguata
e persino involutiva rispetto agli obiettivi dichiarati per il suo conseguimento.
In un’epoca ancora drogata dal mito della crescita illimitata, la crisi ecologica ci obbliga a scegliere
la strada della ‘cura’ e del ‘limite’. E ci avverte che, come ci ricorda Grazia Francescato, se vogliamo
conservare il pianeta e il nostro futuro, ci vuole un salto di qualità della coscienza collettiva.
Il libro intende aiutare a leggere gli avvenimenti connessi alle trasformazioni urbane e territoriali con
un’ottica libera dai rituali ricorrenti che hanno assunto il valore di dogmi, come l’efficienza del
privato rispetto all’insanabile inefficienza del pubblico, la deregulation come cura alla lentezza
prodotta da regole e controlli, la concentrazione delle decisioni in organi monocratici che la
sottraggono ad assemblee elettive con l’intento di snellire le procedure. Ma per guidare la città verso
un’alternativa di progresso, verso uno sviluppo democratico che ammetta la supremazia dei bisogni
della Terra su quelli della finanza, il solo modo è quello di non inquinare le proposte con ricette
sbagliate, che spesso sono state la causa della situazione attuale e aggravano la malattia che affligge
le città. La città è infatti un “organismo complesso” e, come nella medicina, se si sbaglia la diagnosi,
si sbaglia la cura. E come dimostra l’inadeguatezza della città contemporanea è ciò che finora è
avvenuto.